Maggio 2012
Monthly Archive
25 Maggio 2012
Posted by X under
Connettivismo | Tag:
Alan D. Altieri,
Blade Runner,
Blue Velvet,
Città Oscura,
Corridore nella pioggia,
cyberpunk,
Dino De Laurentiis,
Dune,
fantascienza,
Frederick Forsyth,
globalizzazione,
hard-boiled,
James Ellroy,
Kondor,
L'occhio sotterraneo,
L'uomo esterno,
OdB,
Phoenix,
poliziesco,
Raymond Chandler,
Silent Trigger,
Sniper,
spy story,
tecno-thriller,
The Year of the Quiet Sun,
thriller,
Total Recall,
Ultima luce,
Wilson Tucker |
[4] Comments
Per il profilo di Alan D. Altieri rimandiamo alla prima parte di questo mini-speciale.
 Laureato al Politecnico di Milano in Ingegneria Meccanica, scrittore, nei primi anni ’80 ti sei avvicinato all’industria cinematografica americana. Vuoi dirci come si è compiuto il tuo incontro con il mondo della celluloide, e in che modo la tua attività di scrittore si lega – si concilia – a quella di scrittore per il cinema?
Laureato al Politecnico di Milano in Ingegneria Meccanica, scrittore, nei primi anni ’80 ti sei avvicinato all’industria cinematografica americana. Vuoi dirci come si è compiuto il tuo incontro con il mondo della celluloide, e in che modo la tua attività di scrittore si lega – si concilia – a quella di scrittore per il cinema?
Quello che si sa di me è del tutto corretto. Dopo la laurea (1976) ho effettivamente lavorato per sei anni come ingegnere. Fino al grosso mutamento del 1983.
Il merito, se vogliamo dire così, del mio ingresso nel cinema americano va soprattutto al mio primo editore italiano, il grande Andrea Dall’Oglio. Nella primavera del 1983, fu lui a inviare a Dino De Laurentiis Città Oscura, il mio primo libro pubblicato (1981). Dino lo trovò interessante, mi chiamò a New York e mi fece “la classica offerta che non si può rifiutare”.
Al tempo stesso, sono sempre un ingegnere. È una disciplina che si basa sulla logica e che mi continua a fornire un enorme aiuto nella comprensione dei problemi e nella strutturazione delle storie.
In qualità di story editor, produttore esecutivo e senior staff editor per Dino De Laurentiis hai preso parte a progetti di indiscutibile prestigio quali Conan il Distruttore, L’Anno del Dragone, Atto di Forza e Velluto Blu, legati a nomi eccellenti dell’industria americana (e spesso in contrasto con l’establishment hollywoodiano): Michael Cimino, Oliver Stone, Paul Verhoeven, David Lynch. Ti va di parlarci della tua esperienza e magari svelarci qualche succulento aneddoto?
La “descoverta de le Americhe” in generale e di “Hollywood” – virgolette d’obbligo, o anche “Hollyweird” – non è stato un processo né semplice, né facile, né indolore. Per me rimane comunque un’esperienza unica e fondamentale.
In questa sede dovrò necessariamente essere breve. Gli uomini di cui sopra sono tutti talenti straordinari, anche se nei modi più diversi e antitetici. Cimino è un perfezionista cartesiano, Stone un autentico regista d’assalto di enorme capacità evocativa, Verhoeven un fenomenale “meccanico” affascinato dalla “femmina” (non proprio archetipica) in tutte le sue forme, Lynch è un esploratore del lato oscuro. Da ognuno di loro ho imparato qualcosa che poi ho cercato di mettere in pratica nelle mie esperienze successive di scrittore. Aneddoti succulenti? Non basterebbe la Encyclopedia Britannica per elencarli tutti. Mi limiterò a riportare un corrosivo appunto anonimo che trovai affisso in una bacheca dei Churubuscos Studios, a Mexico City, durante la lavorazione di “Dune” e di “Conan il Distruttore”.
Le cinque fasi della realizzazione di un film:
1) pazzo entusiasmo;
2) totale disperazione;
3) ricerca del colpevole;
4) condanna dell’innocente;
5) ricompensa dell’incompetente.
Well, how about that now?
Dal 1994 sei membro della Writers’ Guild of America, e nelle vesti di sceneggiatore hai collaborato alla realizzazione di un numero di film di tutto rispetto. Qual è il lavoro di cui vai maggiormente fiero?
Il formato della sceneggiatura è uno straordinario strumento narrativo. È la ricerca di un equilibrio stabile tra analisi e sintesi, tra emotività (dei personaggi) e necessità visuali (del film stesso). Nei miei dieci anni di sceneggiatore a tempo pieno (1987/1997) ho scritto oltre quaranta tra sceneggiature, trattamenti e soggetti. Quelli che – forse con una certa dose di presunzione – ritengo essere miei migliori lavori di sceneggiatura rimangono non realizzati. Al tempo stesso, Silent Trigger, il thriller del 1995 diretto da Russell Mulcahy (Highlander) e interpretato da Dolph Lundgren, rimane quanto di più vicino io abbia mai potuto sperare in una fedele trasposizione dalla parola scritta all’immagine.
sintesi, tra emotività (dei personaggi) e necessità visuali (del film stesso). Nei miei dieci anni di sceneggiatore a tempo pieno (1987/1997) ho scritto oltre quaranta tra sceneggiature, trattamenti e soggetti. Quelli che – forse con una certa dose di presunzione – ritengo essere miei migliori lavori di sceneggiatura rimangono non realizzati. Al tempo stesso, Silent Trigger, il thriller del 1995 diretto da Russell Mulcahy (Highlander) e interpretato da Dolph Lundgren, rimane quanto di più vicino io abbia mai potuto sperare in una fedele trasposizione dalla parola scritta all’immagine.
Tornando alla tua attività di scrittore, che hai più volte dichiarato di aver privilegiato ultimamente, sei stato definito da Oreste Del Buono il padre fondatore dello “spaghetti tecno-thriller”. Ti riconosci in questa definizione o preferiresti evitare di essere inquadrato in un genere?
Al contrario, sono ben lieto, addirittura orgoglioso (parola forse ingombrante) di fare parte di questo genere in particolare. Il grande snobismo della narrativa italiana è la distinzione tra narrativa “di cultura” e tutto quello che resta. A mio parere, si tratta di una linea di confine assolutamente fasulla. La narrativa è narrativa, punto e basta. È raccontare storie con un principio, un centro e una fine. Storie di conflitti umani, interni ed esterni. Un giorno remoto forse qualcuno ci spiegherà per quale motivo lo Strega premia la cultura mentre il Bancarella premia la scrittura. Da parte mia, intendo rimanere un narratore.
In effetti se c’è una cosa di te che crea particolari difficoltà ai compilatori delle quarte di copertine è quella di ingabbiarti in un genere predefinito. Nei tuoi lavori la contaminazione tra i generi raggiunge livelli inusitati, toccando poliziesco, thriller, azione bellica, spionaggio e chi più ne ha… Ci sono stati dei modelli che ti hanno aiutato a delineare questo tuo stile inconfondibile?
Forse alla parola “inconfondibile” dovremmo sostituire l’espressione “ibrido estremo”. Ritengo che oggi, alba del XXI Secolo, con tutto quello che esiste alle nostre spalle – letterariamente e narrativamente parlando – sia molto difficile scrivere nell’ambito di generi “puri”. Il mio primo libro, il già menzionato Città Oscura era già un ibrido di thriller, hard-boiled e apocalittico. Quindici anni più tardi, Kondor è un ibrido di thriller, war-story e, nemmeno a dirlo, apocalittico. Penso che solamente il poliziotto molto hard-boiled di Corridore nella pioggia e il killer molto “alla John Woo” de L’uomo esterno siano i personaggi meno ibridi da me messi in campo. Sostanzialmente, l’ibrido estremo è e rimarrà una componente basilare delle mie storie.
Per contro, i modelli, certo. La mia icona assoluta rimane Raymond Chandler. È l’autore che ha ridefinito il concetto di “cavaliere con alcune macchie, nessuna paura e molti dubbi”. Quanto alla struttura e complessità delle storie, Frederick Forsyth prima maniera è uno degli autori che più mi hanno influenzato.
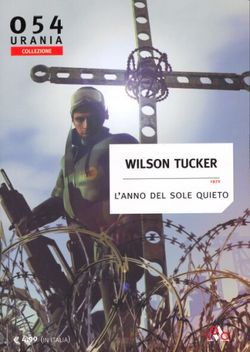 Sebbene spesso relegata a puro elemento di contorno, la fantascienza fa spesso capolino nelle tue opere, talvolta nella forma della fantapolitica o del thriller tecnologico. Cos’è che maggiormente ti affascina delle sue risorse, al punto da spingerti a farne un uso così ampio?
Sebbene spesso relegata a puro elemento di contorno, la fantascienza fa spesso capolino nelle tue opere, talvolta nella forma della fantapolitica o del thriller tecnologico. Cos’è che maggiormente ti affascina delle sue risorse, al punto da spingerti a farne un uso così ampio?
A tutti gli effetti, io “vengo” dalla fantascienza. Da ragazzino divoravo gli scaffali di Urania, Galaxy e Galassia a casa dei miei genitori. Per inciso, nei miei anni di Hollywood arrivai a prendere un’opzione e a scrivere una sceneggiatura del grandissimo Year of the Quiet Sun (L’Anno del Sole Quieto, candidato sia al Premio Hugo che al Premio Nebula) lo straordinario apologo sul time-travel di Wilson Tucker.
Oggi, ritengo che ci ritroviamo letteralmente immersi nella fantascienza. Dall’Internet al “tempo reale”, dalla banda larga a Echelon, dai laboratori virali Livello 4 all’ingegneria genetica. Tutto questo È fantascienza. Troppo spesso viene dato per scontato, non sufficientemente analizzato. Ecco perché in un modo o nell’altro, in una misura o nell’altra, la fantascienza entra e continuerà a entrare nel mio lavoro: il pianeta più alieno di tutti è la Terra.
Caso più unico che raro, la tua produzione si articola – salvo qualche eccezione – in almeno due grandi
filoni coerenti: da una parte la produzione, diremmo, spionistica, dall’altra una saga cominciata con Città Oscura e proseguita attraverso Città di Ombre, Kondor, fino a Ultima Luce, inquadrati in una storia che dal nostro presente si spinge attraverso continui ribaltamenti di prospettiva e cambi d’epoca fino alla metà circa del secolo XXI. Personaggi e rimandi ad eventi ed organizzazioni si ripetono e mantengono solido il legame tra queste opere altrimenti caratterizzate da ambientazioni e perfino generi diversi. Puoi parlarci un po’ di questo progetto, che se ho ben capito dalle illazioni circolanti in Rete saresti addirittura propenso a proseguire nell’imminente futuro?
Hai centrato in pieno: i miei libri stanno entrando – alcuni più altri meno – a fare parte di un’unica “meta-struttura” narrativa. Fino ad adesso, solamente L’Occhio Sotterraneo – per la natura intrinseca del libro – ne e’ al di fuori.
La serie Sniper – che sto scrivendo per Mondadori Segretissimo e che viene riproposta dalla TEA – mi fornisce un’ottima piattaforma di riferimenti incrociati. In Sniper 2: L’Ultimo Muro (che apparirà in TEA il prossimo marzo 2005) appaiono niente meno che Wolf Hellstrom e Ivan Ratoff di Alla fine della notte. Appare anche un personaggio femminile, Dendra Yaegen, che in un futuro non troppo lontano potrebbe fare nuovamente parlare di sé.
Infine, ormai in molti dei miei libri, appare Ben Yurick, enigmatico pilota da guerra che presentai per la prima volta nel racconto Phoenix. Yurick uomo che proviene da un tempo “diverso” ma che continua a “tornare”, una sorta di testimone della follia distruttiva di tutto e di tutti.
Per cui, rispondendo apertamente alla domanda: sì, il progetto della “meta-struttura” narrativa è destinato a continuare.
Alcuni elementi della tua scrittura sono distintivi della tua penna (battute secche, stile scarno ed
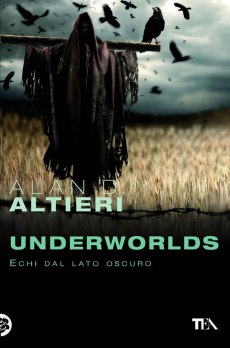 essenziale, grande ritmo e personaggi sempre in bilico tra il bene e il male, verrebbe quasi da dire “tra il peggio e il meno peggio” se mi passi l’espressione). Altri invece sembrano mutuati da grandi scuole anglosassoni, come l’hard-boiled che si riscontra nella profusione di dettagli della tua scrittura iperrealistica e il cyberpunk delle città sovrappopolate del nostro futuro, degli onnipotenti conglomerati economico-commerciali (a proposito, la tua Gottschalk-Yutani Corporation mi sembra parente stretta della Weyland-Yutani Corporation, e qui torniamo al discorso della commistione tra cinema e letteratura), degli individui in lotta contro il sistema e della tecnologia invasiva. In che rapporti sei con l’influsso di questi movimenti?
essenziale, grande ritmo e personaggi sempre in bilico tra il bene e il male, verrebbe quasi da dire “tra il peggio e il meno peggio” se mi passi l’espressione). Altri invece sembrano mutuati da grandi scuole anglosassoni, come l’hard-boiled che si riscontra nella profusione di dettagli della tua scrittura iperrealistica e il cyberpunk delle città sovrappopolate del nostro futuro, degli onnipotenti conglomerati economico-commerciali (a proposito, la tua Gottschalk-Yutani Corporation mi sembra parente stretta della Weyland-Yutani Corporation, e qui torniamo al discorso della commistione tra cinema e letteratura), degli individui in lotta contro il sistema e della tecnologia invasiva. In che rapporti sei con l’influsso di questi movimenti?
Che mi occupi di gangster a Los Angeles o di Special Forces in Medio Oriente, le mie tematiche chiave non mutano:
1) il conflitto del singolo con un enorme potere, per definizione malefico;
2) il conflitto del singolo con il proprio “lato oscuro”.
La domanda che mi poni è valida e parte della risposta può essere trovata nella risposta precedente in cui parlo dell’ibrido estremo. Ritengo che la tematica definisca lo stile. Non escludo affatto di scrivere un thriller feroce nello stile sincopato e anfetaminico che richiami quello del prodigioso James Ellroy.
Quanto ai mega-conglomerati, ebbene sì: Gottschalk-Yutani Corp. È parente stretta della Weyland-Yutani Corp. Una sua antesignana? Forse. Non dimentichiamo che il nuovo crimine planetario è la famosa ma soprattutto famigerata globalizzazione.
Si costruiscono catene di industrie pesanti a sud del confine Stati Uniti/Messico (maquiladoras), nelle quali gli operai lavorano quattordici ore al giorno senza aria condizionata, senza assistenza sanitaria e senza copertura sindacale. E si fanno lavorare bambini pakistani sotto gli otto anni di età a costruire mattoni per sedici ore al giorno a cinquanta cent la settimana. Ah, le gioie del costo del lavoro zero…
Tutto questo è destinato a scoppiarci in faccia. È proprio “lo strano attrattore” della meccanica del caos a dirlo, e non entro nei dettagli della equazione logistica e dei limiti intrinseci dei sistemi a molte variabili complesse. Quindi è proprio là, nelle mega-corporazioni, soprattutto militari, che prosperano i “cattivi” delle mie storie. Da qui le ibridazioni cyberpunk e le atmosfere alla Blade Runner di Ultima Luce, quello che potrebbe essere il destino terminale delle megalopoli.
24 Maggio 2012
Posted by X under
Connettivismo | Tag:
Alan D. Altieri,
Alla fine della notte,
Armageddon,
Blue Velvet,
Città Oscura,
Corridore nella pioggia,
cyberpunk,
Dashiell Hammett,
Death Economy,
Dino De Laurentiis,
Dune,
Epix,
fantascienza,
George R. R. Martin,
Giuseppe Lippi,
globalizzazione,
hard-boiled,
Kondor,
L'occhio sotterraneo,
L'uomo esterno,
Magdeburg,
OdB,
Pentalogia di Los Angeles,
poliziesco,
Raymond Chandler,
Segretissimo,
Sergio Leone,
Sniper,
spy story,
tecno-thriller,
The Year of the Quiet Sun,
thriller,
Total Recall,
Ultima luce,
Urania,
Wilson Tucker |
[2] Comments

Sergio “Alan D.” Altieri è uno degli assi portanti dell’immaginario di genere in Italia. Per molti versi, il lavoro che ha svolto e continua a svolgere in ambito fantastico, poliziesco e spionistico (non solo come autore, ricordiamo che è anche traduttore e che ha rivestito per una lunga e memorabile stagione, dal 2006 al 2011, il ruolo di Editor del mass market Mondadori, lavorando a stretto contatto con Giuseppe Lippi per Urania e le sue sorelle Urania Collezione e la compianta Epix, e curando le altre collane da edicola made in Segrate, Il Giallo Mondadori, I Classici del Giallo, Segretissimo e Segretissimo-SAS, senza tralasciare l’importantissima esperienza borderline de Il Giallo Mondadori Presenta…), può essere accostato a quello di un ingombrante omonimo, punto di riferimento del western e non solo: l’immenso Sergio Leone. Non a caso Oreste Del Buono, oltre a definirlo “il più americano degli scrittori italiani”, coniò per lui l’appropriata definizione di spaghetti techno-thriller.
Alla prossima NextCon, inserita nella cornice della Italcon di Bellaria, sabato 26 maggio Altieri sarà ospite d’onore, avendo accettato l’invito del curatore della convention connettivista Sandro Battisti. Vogliamo cogliere l’occasione per riproporvi un’intervista ormai storica rilasciata da Altieri al defunto blog Uno Strano Attrattore (perduto, come “lacrime nella pioggia”, con la chiusura della piattaforma di Splinder) e parlare della sua opera, che da allora si è arricchita di importantissimi tasselli, non ultima l’ambiziosa e micidiale Trilogia di Magdeburg. Per consentire ai lettori una più facile fruizione di questo mini-dossier su Altieri, abbiamo pensato di dividerlo in due parti. Il post odierno è quindi dedicato a tracciare un profilo dell’autore e della sua opera, eclettica e variegata. Domani invece riproporremo la lunga intervista di cui sopra, che nel frattempo non ci sembra invecchiata di un solo minuto. (altro…)
22 Maggio 2012
 China Miéville in pochi anni è diventato uno degli scrittori imprescindibili della narrativa fantastica, dimostrando un’eccezionale abilità narrativa, risolutezza ed effervescenza di idee e di immaginazione, nonché capacità di intessere storie avvincenti e inedite. Embassytown, pubblicato nel 2011, ne è una straordinaria riconferma.
China Miéville in pochi anni è diventato uno degli scrittori imprescindibili della narrativa fantastica, dimostrando un’eccezionale abilità narrativa, risolutezza ed effervescenza di idee e di immaginazione, nonché capacità di intessere storie avvincenti e inedite. Embassytown, pubblicato nel 2011, ne è una straordinaria riconferma.
Premetto che la mia opinione è indubbiamente di parte, poiché il romanzo è incentrato su una tematica che mi affascina moltissimo in tutte le sue variegate declinazioni, ovvero il linguaggio. Embassytown, infatti, poggia su un solido sostrato speculativo, che non si traduce in pesanti digressioni meramente teoriche, bensì si fonde con trama e descrizioni per dar vita a un’immersione narrativo-sensoriale-filosofica.
Lo stile caratteristico di questo libro potrebbe essere una delusione o noioso per chi preferisce costruzioni essenzialmente incentrate sul susseguirsi di azione, climax e avvenimenti. Per affrontare Embassytown e gustarlo appieno bisogna lasciarsi avvolgere dal romanzo stesso, dalle impressioni, a volte distinte altre sfocate, che suggerisce.
La storia è narrata direttamente dalla protagonista, Avice Benner Cho, attraverso il suo peculiare punto di vista, filtrato dalla sua percezione e dalle sue emozioni, e dal ricordo degli eventi passati. È spiazzante, soprattutto all’inizio: ci si ritrova in una realtà altra, senza punti di riferimento o dettagli grazie ai quali ricostruire questo mondo intrigante ma sconosciuto, che si svela soltanto nello svolgersi della storia. La complessità – e bellezza – del romanzo non è dovuta solamente a questo aspetto – una vaghezza studiata e cesellata – ma soprattutto allo stile e alle scelte linguistiche, talora ardite, arricchite da termini presi da altre lingue o costrutti inediti o particolari. È un romanzo che non tende a spiegare minuziosamente, che non si profonde in passi retorici, ma mira a coinvolgere in maniera appassionata e magnetizzante, per far riflettere e trasmettere il proprio messaggio proprio grazie ad un forte coinvolgimento empatico, emotivo e figurativo.
La storia si svolge su un pianeta alieno, ove si è stabilita una colonia di esseri umani che convivono in base a delicati equilibri con la specie aliena degli Ariekei, chiamati anche Hosts. Gli Ariekei sono affatto singolari ed estremamente affascinanti: una sorta di ibrido, con sottili e ampie ali e due bocche. La loro peculiarità – un elemento vitale, sacro oserei dire – è il linguaggio, che emettono dalle due bocche distinte, pronunciando ogni parola simultaneamente a due voci, senza alcuna distinzione tra fonia e significato, soprattutto senza mai poter mentire – poiché la loro lingua può riferirsi soltanto a cose reali ed esistenti. Gli esseri umani, abitanti di Embassytown, per poter comunicare e relazionarsi con gli Ariekei, hanno creato, in seguito a manipolazioni genetiche e alla biotecnologia, gli Ambassadors, gli Ambasciatori, individui di spicco, uniti in coppia, Rappresentanti degli umani stessi. Talvolta gli Ariekei, consci della difficoltà di comunicare e comprendere concetti ed idee a loro estranei, utilizzano dei soggetti umani particolarmente predisposti, che fungono da sorta di tramite di quanto inesprimibile altrimenti. Tra costoro c’è anche Avice, che oltre ad essere una immerser – ossia capace di fluttuare, navigare e orientarsi nella parte più sconosciuta dello spazio, l’immer – è stata scelta anche per essere una simile.
“Before the humans came, we didn’t speak so much of many things. Before the humans came, we didn’t speak”. Questa è una esemplificazione della forza dirompente di Embassytown, del saper discorrere attraverso una storia accattivante della fragilità e della doppiezza del linguaggio, del suo significato e del suo senso stesso di esistere, sulla sua enigmaticità ontologica, il suo essere punto di riferimento, di vicinanza ma anche di diversità tra civiltà differenti, del suo legame così ambiguo con la realtà esistente e con l’immaginazione. In un certo senso, questa considerazione si potrebbe tradurre come una riflessione sulla narrativa fantastica stessa, in tutte le sue ramificazioni: come e quale linguaggio può utilizzare una storia che narra qualcosa che non esiste? Raccontando l’immaginario, il linguaggio rende reale ciò che non è oppure è soltanto un susseguirsi di inganni? Queste e altre speculazioni possibili sono infinite e tutte meravigliose, così intrinsecamente connaturate all’esistenza stessa, così disorientanti perché spogliano l’uomo di alcune certezze basilari – l’esistenza di ciò che è a cui egli dà nome.
Se la tematica richiama Babel-17 di Samuel R. Delany, Embassytown si colloca decisamente su un altro livello, è molto più profondo, sofferto, sottende un dramma esistenziale-filosofico ben più forte. Un palpito simile, soprattutto nell’intima, tormentata e delicata contrapposizione tra l’uguale e il diverso (uomo/alieno), mi ricorda maggiormente alcune straordinarie pagine di Ursula K. Le Guin; così come alcune riflessioni sul legame ontologico tra linguaggio e realtà non ha potuto non richiamarmi lo straordinario dibattito interno alla poesia italiana del Novecento.
Un romanzo, quindi, che assorbe completamente, affascina, dai tratti talora così intimi quanto in altri passi quasi epici, che, nonostante non sia impeccabile, personalmente credo si possa annoverare non solo come alto esempio di narrativa fantastica, ma osare classificare come letteratura.
17 Maggio 2012
Posted by X under
Immaginario | Tag:
Battlestar Galactica,
Blade Runner,
cinema,
cyberpunk,
Deus Ex,
Do Androids Dream of Electric Sheep?,
Eidos Interactive,
fantascienza,
Ghost in the Shell,
hard-boiled,
Harrison Ford,
Ladd Company,
Mamoru Oshii,
Masamune Shirow,
noir,
Philip K. Dick,
Richard K. Morgan,
Ridley Scott,
Ronald D. Moore |
[7] Comments
Sul sito ufficiale dedicato a Philip K. Dick, precursore del nostro immaginario, gli eredi dell’autore californiano hanno pubblicato una lettera inedita indirizzata a Jeff Walker della Ladd Company, una delle società che parteciparono alla produzione di Blade Runner. La lettera, che trasmette un entusiasmo contagioso, si segnala come documento incontestabile del livello di gradimento che il lavoro di Ridley Scott seppe guadagnarsi da parte dell’autore che ne aveva fornito l’ispirazione, oltre che del punto di vista di Dick sulla fantascienza di quegli anni.
pubblicato una lettera inedita indirizzata a Jeff Walker della Ladd Company, una delle società che parteciparono alla produzione di Blade Runner. La lettera, che trasmette un entusiasmo contagioso, si segnala come documento incontestabile del livello di gradimento che il lavoro di Ridley Scott seppe guadagnarsi da parte dell’autore che ne aveva fornito l’ispirazione, oltre che del punto di vista di Dick sulla fantascienza di quegli anni.
Suscita una certa emozione leggerne i passaggi, perché la lettera testimonia anche il livello di coinvolgimento a cui giunse Dick semplicemente guardando uno spezzone di Blade Runner, trasmesso durante un servizio che ospitava anche un’intervista a Harrison Ford all’interno di un programma sul cinema mandato in onda dall’emittente locale Channel 7. L’autore rimase sinceramente impressionato dall’estetica di Ridley Scott, apprezzò il lavoro dei diversi artisti e tecnici coinvolti nell’adattamento cinematografico di Do Androids Dream of Electric Sheep? e infine si spinse a profetizzare, sull’onda dell’entusiasmo, una rinascita della fantascienza che negli ultimi anni – secondo il suo giudizio, forse un po’ troppo severo – era “scivolata in una morte monotona”, diventando “fragile, derivativa e stantia”.
Il documento fa la sua apparizione nell’anno del trentesimo anniversario dell’uscita nelle sale del capolavoro di Scott, oltre che della prematura scomparsa di Dick che abbiamo già avuto modo di commemorare, sia su HyperNext (in tre puntate: prima, seconda e terza) che in maniera più organica sulle pagine di Delos. Dick seppe cogliere le sfumature di un’opera complessa e, in maniera istintiva, grazie alla sua spiccata sensibilità, riuscì anche ad anticipare l’impatto che sia dal punto del linguaggio che dei contenuti il film avrebbe esercitato negli anni a seguire, sulla letteratura di genere, sul cinema tout-court ma anche sulle forme d’arte più varie (“potreste aver creato una nuova forma, unica nel suo genere, di espressione artistica, qualcosa di mai visto prima”, scrive nella sua lettera a Walker). Dopo le esperienze del cyberpunk e il successo delle declinazioni di temi intrinsecamente fantascientifici secondo gli stilemi della letteratura noir e hard-boiled, è difficile smentire le sue previsioni. E gli echi che se ne riescono a cogliere tuttora nelle opere più disparate e in particolare in capolavori della letteratura di SF (come la trilogia di Kovacs di Richard K. Morgan), del cinema (si pensi a Strange Days di Kathryn Bigelow), dell’animazione (Ghost in the Shell di Mamoru Oshii, da un manga di Masamune Shirow), dei videogiochi (Deus Ex di Warren Spector, prodotto dalla Eidos Interactive) e della televisione (in misura palese nella straordinaria epopea spaziale di Battlestar Galactica, reinventata da Ronald D. Moore e David Eick), stanno a dimostrare che la sua influenza è ben lungi dall’estinguersi.
Per consentire un accesso diretto ai contenuti della lettera di Dick, la pubblichiamo in una traduzione integrale subito dopo il salto. (altro…)
15 Maggio 2012
La vita è informazione trasmessa da molecole complesse: l’RNA e il DNA. Le ricerche sul codice genetico che nel 1962 valsero il Premio Nobel per la medicina a Watson, Crick e Wilkins sono alla base della nostra attuale, se pur parziale, comprensione delle basi genetiche della vita. Il modello a doppia elica visualizzato da Odile Speed, moglie di Crick, ha saputo rendere popolare un concetto per molti versi paradossale: il fatto che le informazioni che definiscono le caratteristiche della specie a cui una creatura vivente appartiene e i tratti particolari che definiscono il singolo individuo siano codificate in una stringa molecolare. Il DNA è una macromolecola costituita dalla ripetizione di unità di base e nelle cellule umane è solitamente ripartito in 23 coppie di cromosomi, che nell’insieme costituiscono il genoma umano, formati da circa tre miliardi di basi azotate, per una lunghezza compresa tra 1 e 2 metri, impacchettato per superavvolgimento e racchiuso nel nucleo di ogni nostra cellula. Ogni unità si chiama nucleotide ed è il monomero della catena a doppia elica (definita polimero). Ciascun nucleotide comprende tre sotto-unità:
- una base azotata
- uno zucchero pentoso (contenente cinque atomi di carbonio)
- un gruppo fosfato

Struttura schematica di un segmento di DNA.
La base azotata può essere una di cinque tipi: adenina (A), citosina (C), guanina (G), timina (T) e uracile (U). Le basi azotate si legano a due a due attraverso dei legami a idrogeno. DNA e RNA (una macromolecola più semplice, formata da un singolo filamento, altrettanto importante nella trasmissione delle informazioni biochimiche a livello cellulare) comprendono un sottogruppo dell’insieme di queste basi, ciascuno formato da quattro di esse. Il DNA, in particolare, è formato da coppie A-T oppure C-G. Nell’RNA l’uracile prende il posto della timina.
Lo zucchero è il ribosio per l’RNA, il desossiribosio per il DNA. Il complesso di una base azotata e uno zucchero pentoso forma un nucleoside. La presenza del gruppo fosfato è responsabile del carattere acido di questi polimeri, da cui il loro nome: acido ribonucleico (RNA) e acido desossiribonucleico (DNA). L’aggiunta di uno o due residui fosforici alla molecola è all’origine della formazione di un nucleoside difosfato o trifosfato (NDP e NTP, rispettivamente), fondamentali per i processi energetici cellulari. In particolare, la reazione per idrolisi che trasforma l’adenosina trifosfato (ATP) in adenosina difosfato (ADP) è la fonte di energia utilizzata dalla cellula per il proprio sostentamento.
In questa brevissima e lacunosa esposizione abbiamo incontrato le due caratteristiche essenziali della vita: informazione da trasmettere ed energia da consumare. Un gioco le cui regole sono severamente iscritte nei vincoli imposti dalla natura e ricordati nella composizione dei nucleotidi di cui sopra, ritenuti non a caso i «mattoni della vita». Da tempo biologi e biochimici s’interrogano sulla validità di queste regole e sui possibili gradi di libertà estraibili dalle restrizioni che impongono. Per esempio: possono esistere polimeri funzionali fondati su altre basi azotate diverse dalle cinque canoniche? Oppure: potremmo sostituire il ribosio e il desossiribosio con un altro zucchero pentoso?

Schema del DNA e alcuni zuccheri pentosi alternativi al desossiribosio.
Diversi team di ricercatori sparsi per il mondo sono giunti quasi simultaneamente ad annunciare nei giorni scorsi i risultati dei loro esperimenti condotti su quest’ultimo fronte. In particolare, un gruppo britannico del Medical Research Council di Cambridge, guidato da Vitor B. Pinheiro, ha esplorato le possibilità degli XNA, ovvero i cosiddetti acidi xenonucleici, come sono stati definiti gli acidi genetici ottenuti usando zuccheri pentosi diversi dal ribosio e dal desossiribosio. Come riportato da Le Scienze, gli zuccheri presi in considerazione sono l’arabinosio, il 2-fluoro-arabinosio, il treosio, un analogo bloccato del ribosio, l’anidroesitolo e il cicloesene, che originano le varianti ANA, FANA, TNA, LNA, HNA e CeNA degli acidi nucleici finora noti. Per tutti questi XNA, è stato possibile ricavare in laboratorio uno strumento fondamentale alla trasmissione dell’informazione genetica in essi codificati, la polimerasi, vale a dire un enzima capace di leggere, trascrivere e retrotrascrivere le sequenze di acidi nucleici. Non essendo presenti in natura molecole di XNA, non esistevano finora nemmeno le corrispondenti polimerasi. I ricercatori britannici sono riusciti ad assemblare polimerasi artificiali in grado di trascrivere l’informazione del DNA in un XNA e, viceversa, retrotrascrivere l’informazione dall’XNA al DNA.
L’ipotesi riconosciuta da Pinheiro e colleghi è che l’XNA possa funzionare come acido nucleico sintetico, ma è ancora presto per parlare di un sistema genetico del tutto autosufficiente. Siamo ancora ai primi passi. Tuttavia l’esito delle loro ricerche è interessante anche per un altro aspetto, legato al mistero dell’origine stessa della vita. L’assunzione che l’RNA abbia preceduto nella scala dell’evoluzione il DNA, molto più complesso, è largamente riconosciuta dai biologi, sebbene resti ancora oscuro il passaggio precedente, ovvero la formazione dell’RNA dal mondo pre-biotico. A colmare la lacuna si candiderebbe ora proprio uno degli XNA studiati a Cambridge, il TNA, l’acido treosinucleico, che ha la possibilità di legarsi all’RNA con un accoppiamento di basi antiparallelo (come accade nel DNA). Un altro passo avanti verso il futuro della programmazione della vita, quindi. Ma accompagnato da un salto a ritroso nel passato verso una comprensione autentica del processo, a cui non dovrebbe rimanere estranea un’assunzione di responsabilità nella sua forma più piena.
10 Maggio 2012
All’inizio del 2008, un gruppo di eterogenei artisti europei ha dato vita ad AntiVJ, con l’obiettivo di sviluppare, produrre e promuovere nuove contaminazioni tra arti visive e musica. Il progetto si focalizza su un utilizzo peculiare delle proiezioni e della luce e su come questi due elementi influenzino le nostre percezioni. Combinando strumenti, una solida preparazione tecnica e forme artistiche differenti, i risultati che questi artisti ottengono, di solito durante performance live o attraverso installazioni, sono una vera esperienza artistica neurotonica.
 Tra le loro prime realizzazioni si annoverano le performance di mapping, tecnica di cui sono stati tra i pionieri nel campo delle proiezioni su grande scala e per la quale hanno sviluppato un software specifico. Tecnicamente il tutto è reso possibile dalla generazione e riproduzione di proiezioni stereoscopiche su superfici piane, grazie a potenti videoproiettori e processi di mappatura digitale che danno allo spettatore l’illusione della profondità tridimensionale creando enormi schermi virtuali ad alta precisione. Memorabili sono state le proiezioni in una cattedrale in Olanda, su un futuristico edificio in Corea (esperimento che mirava a rappresentare lo sviluppo urbano di una città-modello e come esso può organizzare le persone in reti controllate ed interconnesse) e su una nave-cisterna in Canada.
Tra le loro prime realizzazioni si annoverano le performance di mapping, tecnica di cui sono stati tra i pionieri nel campo delle proiezioni su grande scala e per la quale hanno sviluppato un software specifico. Tecnicamente il tutto è reso possibile dalla generazione e riproduzione di proiezioni stereoscopiche su superfici piane, grazie a potenti videoproiettori e processi di mappatura digitale che danno allo spettatore l’illusione della profondità tridimensionale creando enormi schermi virtuali ad alta precisione. Memorabili sono state le proiezioni in una cattedrale in Olanda, su un futuristico edificio in Corea (esperimento che mirava a rappresentare lo sviluppo urbano di una città-modello e come esso può organizzare le persone in reti controllate ed interconnesse) e su una nave-cisterna in Canada.
Questa tecnica di mapping sta attirando negli ultimi tempi diversi video designer, come testimoniano le segnalazioni fioccate in rete (un esempio italiano è il progetto La Torre Riflette di Elisa Seravalli). E si configura come un intento di «ricodifica» dell’esistente secondo parametri sensoriali alternativi, concetto vicino e combinato a quello di realtà aumentata e multisensorialità, tematiche trattate anche nell’ultima iterazione di NeXT, intitolata proprio Maps.
Sfogliando gli altri progetti di AntiVJ, un ulteriore risultato degno di attenzione è Principles of Geometry. Utilizzando la stereoscopia (la tecnologia adottata nel cinema 3D) è stato prodotto un viaggio nello spazio della terza dimensione, della durata di ben 50 minuti, attraverso paesaggi wireframe e sottili linee lattescenti intersecanti prospettive infinite, con una colonna sonora realizzata grazie a sintetizzatori d’epoca.
I componenti di AntiVJ sono attivi anche nello studio e nell’applicazione della luce a strutture interattive, tipologia di installazioni che di recente ha avuto parecchia risonanza grazie all’allestimento presso l’autorevole Centro Artistico 104 di Parigi di una collettiva incentrata sull’interazione tra luce, piani spaziali e immagini, che coinvolgeva inoltre gli stessi spettatori. Antivj aveva presentato qualcosa di analogo con il progetto 3Destruct, che in versione completamente rinnovata è stato da poco riproposto a San Pietroburgo e in Francia. 3Destruct è costituito da un grande cubo di fogli semitrasparenti, a cui sono collegati quattro proiettori che ne mappano le superfici, generando luci, flash e suoni: immergendosi totalmente in questa installazione, lo spettatore perde ogni punto di riferimento razionale e coerenza spaziale, coinvolto in una suggestione che va oltre la logica dell’universo lineare.
Questo tipo di sperimentazione ha radici ricollegabili alle realizzazioni di Lucio Fontana, che già attorno agli anni Cinquanta iniziò a impiegare nelle sue opere la luce in senso spaziale, ossia come elemento in grado di rivelare plasticità inedite e creare nuovi ambienti spaziali attraverso proiezioni di immagini luminose e l’alternanza di zone in chiaro ed altre oscure. L’utilizzo di tubi al neon o del sofisticato effetto della luce di Wood diede vita ad alcune delle prime installazioni della storia dell’arte (si pensi ad Ambiente spaziale a luce nera presentato presso la Galleria del Naviglio di Milano nel 1948), caratterizzate da una sensibilità nuova, rivolta a una spazialità dai labili confini e dalle mille suggestioni recondite, tesa tanto verso l’infinito, il mistero, quanto al nulla, al di là dei confini dell’opera stessa, di cui lo spettatore è parte attiva e integrante. Non a caso, la prima silloge di poesie connettiviste porta un titolo deliberatamente ispirato proprio a Fontana, Concetti Spaziali, oltre.
La nuova frontiera artistica proposta da AntiVJ, quindi, riesce a stimolare un’esperienza di percezioni plurime altamente condensate, nella simulazione della realtà aumentata o del multiverso. E chissà quali altri obiettivi e commistioni sensoriali, grazie a un sempre più avanzato impiego della tecnologia (ad oggi si dicono impegnati nella ricerca di nuove soluzioni che fruiscano della scansione 3D, di un nuovo tipo di motion tracking, delle più avanzate interfacce uomo-computer), sapranno ancora testare in futuro questi pionieri della contaminazione artistica.
8 Maggio 2012
La riflessione sul cambiamento può prendere le mosse da due condizioni opposte. Da un lato, il cambiamento stesso può indurre nell’osservatore lo stimolo all’interpretazione e all’estrapolazione, allo scopo di anticiparne e prefigurarne gli esiti, per denunciare un rischio o anche solo per tener fede a un’aspirazione di attendibilità. Dall’altro, la molla innescante può essere la possibilità del cambiamento, l’introduzione di un elemento di divergenza in un contesto inizialmente statico e immobile.
Esiste poi l’intero spettro delle condizioni intermedie, le diverse combinazioni ibride dei due estremi.
Per esempio, pensiamo al mondo che ci circonda. Il progresso tecnologico ha imboccato una china sempre più ripida, le innovazioni si succedono a un ritmo crescente che diventa ogni giorno che passa sempre più vertiginoso. Eppure a questa accelerazione tecnologica non corrisponde quasi mai un’immediata ricaduta sul tessuto sociale. Il telelavoro prefigurato fino a un decennio fa come una delle principali innovazioni che avrebbero interessato il mercato del lavoro è naufragato prima ancora di partire. In compenso, con assurde e paradossali pretese di flessibilità, si è reso il mercato del lavoro sempre più precario e si è prodotta un’intera fascia di disoccupazione giovanile come mai le generazioni che ci hanno precedute avevano avuto modo di conoscere.
Non si può restare insensibili al cambiamento. Come non si può restare indifferenti all’immobilismo. Entrambi ci prospettano situazioni con vari gradi di problematicità. E le situazioni problematiche sono il carburante drammatico di ogni storia. Occorre un esercizio costante e continuato per affinare la sensibilità e riuscirne a cogliere i risvolti, con l’obiettivo di trasfigurarle nei nostri racconti.
7 Maggio 2012
L’hacienda adduce spesso a giustificazione della propria esistenza la realizzazione di prodotti. Ma si osservi il processo generale che li santifica quanto più li svuota, riducendoli infine a gusci cavi, privi di asperità e colore, su cui possa far presa col massimo arbitrio il sudario glorificante della pubblicità: allora risulterà chiaro che tale giustificazione è un pretesto.
Libera dagli obblighi della realtà, l’hacienda genera null’altro che involucri, la cui sostanza si riassume nella mera pretesa affermata perentoriamente dall’etichetta e dalla confezione, e supportata dalla falsa testimonianza dei manuali. Prove fittizie che col loro rimandarsi sortiscono un’illusione di consistenza, mentre si tratta di un circolo vizioso che corre intorno al nulla, e lo protegge. L’incantamento pubblicitario provvede a che ben pochi si avventurino nel tentativo di usare davvero il prodotto; il suggerimento è di conservarlo, per farne collezione o esibirlo al momento opportuno: vien fatto chiaramente intendere che il suo regno non è di questo mondo. Alle lamentele e all’insoddisfazione di quei pochi si fa fronte con le garanzie, esse stesse puramente nominali, e soprattutto negando l’evidenza.
—F.Sollima, Fenomenologia dell’umiliazione, I, p.48
4 Maggio 2012
Posted by X under
Scienze & Tecnologie | Tag:
computazione quantistica,
elettronica,
entanglement,
fisica quantistica,
information technology,
Quantum computer,
quantum information,
quantum network,
qubit,
rete,
spintronica |
Lascia un commento
Dei giorni scorsi sono due notizie alquanto interessanti per gli appassionati di informatica e di elettronica, soprattutto per quanto concerne i potenziali sviluppi futuri della tecnologia dell’informazione.

Spin-wavefunction (Photo credit: Wikipedia)
Nel 2008 si cominciò a parlare anche qui da noi di spintronica, una nuova branca dell’elettronica quantistica il cui campo di applicazione più promettente sembrava essere proprio nel settore dei processori quantistici. Su Fantascienza.com ne parlammo diffusamente, per cui rimandiamo a quell’articolo chiunque volesse approfondire l’argomento. Forti degli studi avviati dai ricercatori dell’Università della California di Santa Barbara, sede del Center for Spintronics and Quantum Computation, dalla loro collaborazione con i colleghi del Politecnico di Delft (Paesi Bassi) e della Iowa State University è nato il prototipo funzionante di una nuovissima classe di processori, che dimostra la fattibilità di computer quantistici allo stato solido. Sicuramente è presto per pensare a una produzione commerciale: stiamo solo muovendo i primi passi verso la nuova frontiera della computazione, ma il risultato raggiunto dagli scienziati dei tre istituti summenzionati dimostra che la direzione è quella giusta.
Il prodotto delle loro ricerche è costituito da un substrato di carbonio cristallino al cui interno sono confinati due qubit (ovvero bit quantistici, le unità di base dell’informazione quantistica), realizzati rispettivamente da un nucleo di azoto introdotto come impurità nel diamante e da un elettrone presente in un altro difetto della struttura. In particolare l’informazione è rappresentata dal loro spin, vale a dire il momento angolare intrinseco o, più intuitivamente, il verso di rotazione del nucleo e dell’elettrone. Questa proprietà delle particelle subatomiche si presta a un’applicazione utile nel campo della computazione quantistica. Il principale degli effetti collaterali con cui occorre fare i conti quando si maneggiano unità di informazione quantistiche è infatti la decoerenza, ovvero il progressivo deterioramento prodotto dalle «interferenze» dell’ambiente esterno sull’informazione immagazzinata nei qubit, e il relativo brevissimo intervallo di tempo in cui essi risultano pertanto manipolabili. La tecnica classica prevede un raffreddamento del sistema a temperature prossime allo zero assoluto (-273,15 gradi Celsius), per ridurre le interazioni con l’esterno congelando di fatto il sistema lontano dal rumore ambientale. Tale processo è però comprensibilmente costoso ed è improbabile pensare a una sua applicazione in dispositivi prodotti su scala commerciale. La soluzione proposta con la spintronica sembra invece molto più facile da realizzare tecnicamente. Il nucleo di azoto, pur essendo un qubit più lento, presenta una certa stabilità rispetto alla decoerenza, che ne preserva lo stato per un tempo sufficientemente lungo da renderne possibile l’utilizzo in processi di elaborazione. L’elettrone rappresenta invece un qubit più veloce, ma è anche maggiormente esposto agli effetti della decoerenza. I ricercatori hanno ideato un espediente per “schermarlo” utilizzando degli impulsi a microonde.
Testato su un problema di ottimizzazione, come la ricerca di una particolare occorrenza all’interno di un database, il processore spintronico avrebbe ottenuto il risultato giusto al primo colpo nel 95% dei casi, un risultato sensibilmente superiore a quello che sarebbe stato lecito aspettarsi da un processore classico basato su un algoritmo di ricerca tradizionale (che avrebbe avuto una sola probabilità sul numero complessivo di elementi della base di dati). Un risultato, secondo gli autori della ricerca pubblicata su Nature, sufficiente a dare ragione del comportamento quantistico del loro prototipo.
Secondo molti esperti, proprio campi specifici come l’ottimizzazione o la crittografia rappresenterebbero il terreno più fertile per le applicazioni dei futuri processori quantistici, che quindi finirebbero per soppiantare i processori tradizionali soprattutto nel settore dei dispositivi special purpose, ovvero progettati per assolvere a compiti complessi ma specifici. Un gruppo di ricerca del Max Planck Institut di Garching (Germania) attivo nell’Ottica Quantistica ha invece già pensato a una possibile rete quantistica. Non dobbiamo tuttavia confondere il loro risultato con il progetto di quantum network avviato a Durban, in Sudafrica, dal Centre for Quantum Technology della locale Università del KwaZulu-Natal e basato sulla crittografia quantistica delle informazioni scambiate dalle strutture pubbliche della municipalità di eThekwini, connesse sulla metropolitan area network (MAN) della città. Lo scopo della ricerca eseguita al Max Planck non si limita alla crittografia, ma ambisce a creare una rete come quelle su cui si basa quotidianamente la nostra comunicazione e interazione remota, ma interamente basata su tecnologie quantistiche.

Elementary quantum network of single atoms in optical cavities.
La rete quantistica implementata a livello prototipale dagli scienziati di Garching consiste infatti in due nodi multifunzione collegati da una fibra ottica e capaci di trasmettere, ricevere e archiviare informazioni quantistiche. I nodi sono costituiti da atomi di rubidio intrappolati in cavità ottiche riflettenti: lo stato quantistico di ciascun atomo rappresenta il qubit. Accoppiando tramite entanglement quantistico lo stato di un nodo a quello di un fotone trasmesso attraverso la fibra si realizza lo scambio di informazione con l’altro nodo. Per il momento il prototipo di rete occupa i laboratori dell’istituto e i nodi distano tra loro 21 metri e sono collegati da una fibra ottica lunga 60 metri, ma non ci sono limiti alla scalabilità dell’applicazione. “Stiamo cercando di costruire un sistema in cui il nodo è l’elemento universale”, spiega Stephan Ritter, coautore dello studio pubblicato su Nature. “Non solo è in grado di inviare e ricevere: in linea di principio potrebbe fare tutto ciò che ci si può immaginare”. Il che significherebbe informazione scambiata velocemente e altrettanto velocemente processata, ma soprattutto comunicazione sicura.
Siamo davanti a due significativi passi in avanti nella strada verso la prossima rivoluzione tecnologica che investirà i campi dell’elettronica e dell’information technology. Ne seguiremo gli sviluppi, tenendo come sempre le nostre antenne ben puntate sulle sorgenti del futuro.
3 Maggio 2012
Sta raccogliendo una ricca serie di premi l’ultimo progetto visivo multidisciplinare, articolato in un cortometraggio, fotografie e dipinti realizzati a tecnica mista, di Alessandro Bavari (artista che ha collaborato anche con NeXT), intitolato Metachaos. Nome emblematico. Come spiega l’autore, deriva “dal greco meta (oltre) e chaos (l’abisso dove si cela lo stato eternamente informe dell’universo), per indicare una forma primordiale di ameba, priva di una precisa morfologia e caratterizzata da progressive mutazioni e mitosi”.
Il cortometraggio è un’allegoria degli aspetti più atroci e corrotti della specie umana e della sua progressiva disumanizzazione (che nel quotidiano corrisponderebbero a guerra, odio, oppressione), rappresentata dalla contrapposizione tra un mondo puro, isolato e protetto da una costruzione simile a una sorta di cubo di Rubik in perenne movimento, e l’esterno, una landa desolata, mefitica, infestata da creature ostili solo apparentemente antropomorfe.
Quando questi esseri demoniaci riescono a irrompere nella fortezza, si propagano come un virus letale e, moltiplicandosi e ramificandosi in maniera incontrollata e inarrestabile, seminano rovina e disfacimento. Un crescendo di devastazione, bestialità, caos, quasi un macabro compiacimento dell’orrore di fango e sporcizia che rigurgita queste creature, man mano sempre più ibridate con rettili e simili a raccapriccianti aracnidi, deliranti in un sabba folle e frenetico che sfocia nell’esplosione finale del tutto in un magmatico e denso brodo primordiale. Due poli antitetici, quindi, benché in un certo senso entrambi estremi nella loro assolutezza, destinati ad annientarsi e autodistruggersi. Una caratterizzazione che si potrebbe far derivare per l’analoga ispirazione a Eloi e Morlock de La Macchina del tempo di Herbert George Wells.
L’impatto del video è reso innanzitutto a livello cromatico, dal contrasto tra l’ecosistema dell’ideale, in cui predominano il colore bianco e movimenti fluidi, e il mondo avverso dominato da tinte sabbia e acide, cupe, che lo rendono già alla vista claustrofobico e minaccioso. Il movimento della videocamera a spalla, il ritmo stordente e sferragliante della colonna sonora, la collisione tra architettura ed esseri viventi, la conformazione delle creature malvagie, dai connotati astratti ma al contempo modellate in una carnalità depravata e in sfacelo, rendono ancor più il senso di tragicità e rovina inesorabile.
Se è stato sottolineato che l’iconografia di questi corpi macilenti, ammassati, sfigurati da follia o dolore proviene da artisti come Hieronymus Bosch e Pieter Bruegel, non è possibile non ricollegarla anche alla bestialità a cui sono ridotte le anime dei trapassati in alcuni passi dell’inferno dantesco nonché a talune scene del Teatro della Crudeltà di Antonin Artaud. Altrettanto mi pare si possano richiamare le opere più lugubri e spettrali di Alfred Kubin e diversi passaggi del suo romanzo L’Altra Parte, nel quale ideale e incubo di sgretolano e si fondono in una mirabile distopia espressionista.
Di fronte a queste immagini aleggiano due domande, taciute forse perché troppo amare: l’essere umano sta degradando davvero in una simile barbarie? L’unica via d’uscita potrebbe essere soltanto la sua distruzione totale? Personalmente spero possano essere da monito per intraprendere una direzione differente.
Pagina successiva »
 Laureato al Politecnico di Milano in Ingegneria Meccanica, scrittore, nei primi anni ’80 ti sei avvicinato all’industria cinematografica americana. Vuoi dirci come si è compiuto il tuo incontro con il mondo della celluloide, e in che modo la tua attività di scrittore si lega – si concilia – a quella di scrittore per il cinema?
Laureato al Politecnico di Milano in Ingegneria Meccanica, scrittore, nei primi anni ’80 ti sei avvicinato all’industria cinematografica americana. Vuoi dirci come si è compiuto il tuo incontro con il mondo della celluloide, e in che modo la tua attività di scrittore si lega – si concilia – a quella di scrittore per il cinema? sintesi, tra emotività (dei personaggi) e necessità visuali (del film stesso). Nei miei dieci anni di sceneggiatore a tempo pieno (1987/1997) ho scritto oltre quaranta tra sceneggiature, trattamenti e soggetti. Quelli che – forse con una certa dose di presunzione – ritengo essere miei migliori lavori di sceneggiatura rimangono non realizzati. Al tempo stesso, Silent Trigger, il thriller del 1995 diretto da Russell Mulcahy (Highlander) e interpretato da Dolph Lundgren, rimane quanto di più vicino io abbia mai potuto sperare in una fedele trasposizione dalla parola scritta all’immagine.
sintesi, tra emotività (dei personaggi) e necessità visuali (del film stesso). Nei miei dieci anni di sceneggiatore a tempo pieno (1987/1997) ho scritto oltre quaranta tra sceneggiature, trattamenti e soggetti. Quelli che – forse con una certa dose di presunzione – ritengo essere miei migliori lavori di sceneggiatura rimangono non realizzati. Al tempo stesso, Silent Trigger, il thriller del 1995 diretto da Russell Mulcahy (Highlander) e interpretato da Dolph Lundgren, rimane quanto di più vicino io abbia mai potuto sperare in una fedele trasposizione dalla parola scritta all’immagine.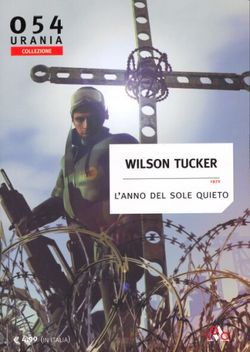 Sebbene spesso relegata a puro elemento di contorno, la fantascienza fa spesso capolino nelle tue opere, talvolta nella forma della fantapolitica o del thriller tecnologico. Cos’è che maggiormente ti affascina delle sue risorse, al punto da spingerti a farne un uso così ampio?
Sebbene spesso relegata a puro elemento di contorno, la fantascienza fa spesso capolino nelle tue opere, talvolta nella forma della fantapolitica o del thriller tecnologico. Cos’è che maggiormente ti affascina delle sue risorse, al punto da spingerti a farne un uso così ampio?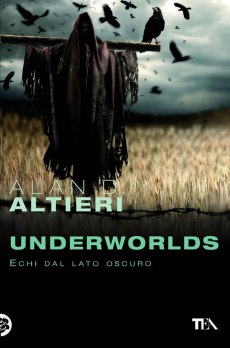 essenziale, grande ritmo e personaggi sempre in bilico tra il bene e il male, verrebbe quasi da dire “tra il peggio e il meno peggio” se mi passi l’espressione). Altri invece sembrano mutuati da grandi scuole anglosassoni, come l’hard-boiled che si riscontra nella profusione di dettagli della tua scrittura iperrealistica e il cyberpunk delle città sovrappopolate del nostro futuro, degli onnipotenti conglomerati economico-commerciali (a proposito, la tua Gottschalk-Yutani Corporation mi sembra parente stretta della Weyland-Yutani Corporation, e qui torniamo al discorso della commistione tra cinema e letteratura), degli individui in lotta contro il sistema e della tecnologia invasiva. In che rapporti sei con l’influsso di questi movimenti?
essenziale, grande ritmo e personaggi sempre in bilico tra il bene e il male, verrebbe quasi da dire “tra il peggio e il meno peggio” se mi passi l’espressione). Altri invece sembrano mutuati da grandi scuole anglosassoni, come l’hard-boiled che si riscontra nella profusione di dettagli della tua scrittura iperrealistica e il cyberpunk delle città sovrappopolate del nostro futuro, degli onnipotenti conglomerati economico-commerciali (a proposito, la tua Gottschalk-Yutani Corporation mi sembra parente stretta della Weyland-Yutani Corporation, e qui torniamo al discorso della commistione tra cinema e letteratura), degli individui in lotta contro il sistema e della tecnologia invasiva. In che rapporti sei con l’influsso di questi movimenti?
 China Miéville in pochi anni è diventato uno degli scrittori imprescindibili della narrativa fantastica, dimostrando un’eccezionale abilità narrativa, risolutezza ed effervescenza di idee e di immaginazione, nonché capacità di intessere storie avvincenti e inedite. Embassytown, pubblicato nel 2011, ne è una straordinaria riconferma.
China Miéville in pochi anni è diventato uno degli scrittori imprescindibili della narrativa fantastica, dimostrando un’eccezionale abilità narrativa, risolutezza ed effervescenza di idee e di immaginazione, nonché capacità di intessere storie avvincenti e inedite. Embassytown, pubblicato nel 2011, ne è una straordinaria riconferma.


 Tra le loro prime realizzazioni si annoverano le performance di mapping, tecnica di cui sono stati tra i pionieri nel campo delle proiezioni su grande scala e per la quale hanno sviluppato un software specifico. Tecnicamente il tutto è reso possibile dalla generazione e riproduzione di proiezioni stereoscopiche su superfici piane, grazie a potenti videoproiettori e processi di mappatura digitale che danno allo spettatore l’illusione della profondità tridimensionale creando enormi schermi virtuali ad alta precisione. Memorabili sono state le proiezioni in una
Tra le loro prime realizzazioni si annoverano le performance di mapping, tecnica di cui sono stati tra i pionieri nel campo delle proiezioni su grande scala e per la quale hanno sviluppato un software specifico. Tecnicamente il tutto è reso possibile dalla generazione e riproduzione di proiezioni stereoscopiche su superfici piane, grazie a potenti videoproiettori e processi di mappatura digitale che danno allo spettatore l’illusione della profondità tridimensionale creando enormi schermi virtuali ad alta precisione. Memorabili sono state le proiezioni in una 

