Per il profilo di Alan D. Altieri rimandiamo alla prima parte di questo mini-speciale.
 Laureato al Politecnico di Milano in Ingegneria Meccanica, scrittore, nei primi anni ’80 ti sei avvicinato all’industria cinematografica americana. Vuoi dirci come si è compiuto il tuo incontro con il mondo della celluloide, e in che modo la tua attività di scrittore si lega – si concilia – a quella di scrittore per il cinema?
Laureato al Politecnico di Milano in Ingegneria Meccanica, scrittore, nei primi anni ’80 ti sei avvicinato all’industria cinematografica americana. Vuoi dirci come si è compiuto il tuo incontro con il mondo della celluloide, e in che modo la tua attività di scrittore si lega – si concilia – a quella di scrittore per il cinema?
Quello che si sa di me è del tutto corretto. Dopo la laurea (1976) ho effettivamente lavorato per sei anni come ingegnere. Fino al grosso mutamento del 1983.
Il merito, se vogliamo dire così, del mio ingresso nel cinema americano va soprattutto al mio primo editore italiano, il grande Andrea Dall’Oglio. Nella primavera del 1983, fu lui a inviare a Dino De Laurentiis Città Oscura, il mio primo libro pubblicato (1981). Dino lo trovò interessante, mi chiamò a New York e mi fece “la classica offerta che non si può rifiutare”.
Al tempo stesso, sono sempre un ingegnere. È una disciplina che si basa sulla logica e che mi continua a fornire un enorme aiuto nella comprensione dei problemi e nella strutturazione delle storie.
In qualità di story editor, produttore esecutivo e senior staff editor per Dino De Laurentiis hai preso parte a progetti di indiscutibile prestigio quali Conan il Distruttore, L’Anno del Dragone, Atto di Forza e Velluto Blu, legati a nomi eccellenti dell’industria americana (e spesso in contrasto con l’establishment hollywoodiano): Michael Cimino, Oliver Stone, Paul Verhoeven, David Lynch. Ti va di parlarci della tua esperienza e magari svelarci qualche succulento aneddoto?
La “descoverta de le Americhe” in generale e di “Hollywood” – virgolette d’obbligo, o anche “Hollyweird” – non è stato un processo né semplice, né facile, né indolore. Per me rimane comunque un’esperienza unica e fondamentale.
In questa sede dovrò necessariamente essere breve. Gli uomini di cui sopra sono tutti talenti straordinari, anche se nei modi più diversi e antitetici. Cimino è un perfezionista cartesiano, Stone un autentico regista d’assalto di enorme capacità evocativa, Verhoeven un fenomenale “meccanico” affascinato dalla “femmina” (non proprio archetipica) in tutte le sue forme, Lynch è un esploratore del lato oscuro. Da ognuno di loro ho imparato qualcosa che poi ho cercato di mettere in pratica nelle mie esperienze successive di scrittore. Aneddoti succulenti? Non basterebbe la Encyclopedia Britannica per elencarli tutti. Mi limiterò a riportare un corrosivo appunto anonimo che trovai affisso in una bacheca dei Churubuscos Studios, a Mexico City, durante la lavorazione di “Dune” e di “Conan il Distruttore”.
Le cinque fasi della realizzazione di un film:
1) pazzo entusiasmo;
2) totale disperazione;
3) ricerca del colpevole;
4) condanna dell’innocente;
5) ricompensa dell’incompetente.
Well, how about that now?
Dal 1994 sei membro della Writers’ Guild of America, e nelle vesti di sceneggiatore hai collaborato alla realizzazione di un numero di film di tutto rispetto. Qual è il lavoro di cui vai maggiormente fiero?
Il formato della sceneggiatura è uno straordinario strumento narrativo. È la ricerca di un equilibrio stabile tra analisi e sintesi, tra emotività (dei personaggi) e necessità visuali (del film stesso). Nei miei dieci anni di sceneggiatore a tempo pieno (1987/1997) ho scritto oltre quaranta tra sceneggiature, trattamenti e soggetti. Quelli che – forse con una certa dose di presunzione – ritengo essere miei migliori lavori di sceneggiatura rimangono non realizzati. Al tempo stesso, Silent Trigger, il thriller del 1995 diretto da Russell Mulcahy (Highlander) e interpretato da Dolph Lundgren, rimane quanto di più vicino io abbia mai potuto sperare in una fedele trasposizione dalla parola scritta all’immagine.
sintesi, tra emotività (dei personaggi) e necessità visuali (del film stesso). Nei miei dieci anni di sceneggiatore a tempo pieno (1987/1997) ho scritto oltre quaranta tra sceneggiature, trattamenti e soggetti. Quelli che – forse con una certa dose di presunzione – ritengo essere miei migliori lavori di sceneggiatura rimangono non realizzati. Al tempo stesso, Silent Trigger, il thriller del 1995 diretto da Russell Mulcahy (Highlander) e interpretato da Dolph Lundgren, rimane quanto di più vicino io abbia mai potuto sperare in una fedele trasposizione dalla parola scritta all’immagine.
Tornando alla tua attività di scrittore, che hai più volte dichiarato di aver privilegiato ultimamente, sei stato definito da Oreste Del Buono il padre fondatore dello “spaghetti tecno-thriller”. Ti riconosci in questa definizione o preferiresti evitare di essere inquadrato in un genere?
Al contrario, sono ben lieto, addirittura orgoglioso (parola forse ingombrante) di fare parte di questo genere in particolare. Il grande snobismo della narrativa italiana è la distinzione tra narrativa “di cultura” e tutto quello che resta. A mio parere, si tratta di una linea di confine assolutamente fasulla. La narrativa è narrativa, punto e basta. È raccontare storie con un principio, un centro e una fine. Storie di conflitti umani, interni ed esterni. Un giorno remoto forse qualcuno ci spiegherà per quale motivo lo Strega premia la cultura mentre il Bancarella premia la scrittura. Da parte mia, intendo rimanere un narratore.
In effetti se c’è una cosa di te che crea particolari difficoltà ai compilatori delle quarte di copertine è quella di ingabbiarti in un genere predefinito. Nei tuoi lavori la contaminazione tra i generi raggiunge livelli inusitati, toccando poliziesco, thriller, azione bellica, spionaggio e chi più ne ha… Ci sono stati dei modelli che ti hanno aiutato a delineare questo tuo stile inconfondibile?
Forse alla parola “inconfondibile” dovremmo sostituire l’espressione “ibrido estremo”. Ritengo che oggi, alba del XXI Secolo, con tutto quello che esiste alle nostre spalle – letterariamente e narrativamente parlando – sia molto difficile scrivere nell’ambito di generi “puri”. Il mio primo libro, il già menzionato Città Oscura era già un ibrido di thriller, hard-boiled e apocalittico. Quindici anni più tardi, Kondor è un ibrido di thriller, war-story e, nemmeno a dirlo, apocalittico. Penso che solamente il poliziotto molto hard-boiled di Corridore nella pioggia e il killer molto “alla John Woo” de L’uomo esterno siano i personaggi meno ibridi da me messi in campo. Sostanzialmente, l’ibrido estremo è e rimarrà una componente basilare delle mie storie.
Per contro, i modelli, certo. La mia icona assoluta rimane Raymond Chandler. È l’autore che ha ridefinito il concetto di “cavaliere con alcune macchie, nessuna paura e molti dubbi”. Quanto alla struttura e complessità delle storie, Frederick Forsyth prima maniera è uno degli autori che più mi hanno influenzato.
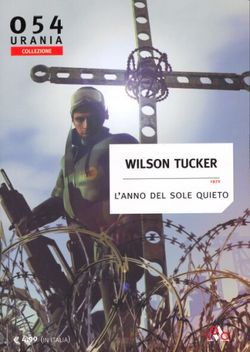 Sebbene spesso relegata a puro elemento di contorno, la fantascienza fa spesso capolino nelle tue opere, talvolta nella forma della fantapolitica o del thriller tecnologico. Cos’è che maggiormente ti affascina delle sue risorse, al punto da spingerti a farne un uso così ampio?
Sebbene spesso relegata a puro elemento di contorno, la fantascienza fa spesso capolino nelle tue opere, talvolta nella forma della fantapolitica o del thriller tecnologico. Cos’è che maggiormente ti affascina delle sue risorse, al punto da spingerti a farne un uso così ampio?
A tutti gli effetti, io “vengo” dalla fantascienza. Da ragazzino divoravo gli scaffali di Urania, Galaxy e Galassia a casa dei miei genitori. Per inciso, nei miei anni di Hollywood arrivai a prendere un’opzione e a scrivere una sceneggiatura del grandissimo Year of the Quiet Sun (L’Anno del Sole Quieto, candidato sia al Premio Hugo che al Premio Nebula) lo straordinario apologo sul time-travel di Wilson Tucker.
Oggi, ritengo che ci ritroviamo letteralmente immersi nella fantascienza. Dall’Internet al “tempo reale”, dalla banda larga a Echelon, dai laboratori virali Livello 4 all’ingegneria genetica. Tutto questo È fantascienza. Troppo spesso viene dato per scontato, non sufficientemente analizzato. Ecco perché in un modo o nell’altro, in una misura o nell’altra, la fantascienza entra e continuerà a entrare nel mio lavoro: il pianeta più alieno di tutti è la Terra.
Caso più unico che raro, la tua produzione si articola – salvo qualche eccezione – in almeno due grandi
filoni coerenti: da una parte la produzione, diremmo, spionistica, dall’altra una saga cominciata con Città Oscura e proseguita attraverso Città di Ombre, Kondor, fino a Ultima Luce, inquadrati in una storia che dal nostro presente si spinge attraverso continui ribaltamenti di prospettiva e cambi d’epoca fino alla metà circa del secolo XXI. Personaggi e rimandi ad eventi ed organizzazioni si ripetono e mantengono solido il legame tra queste opere altrimenti caratterizzate da ambientazioni e perfino generi diversi. Puoi parlarci un po’ di questo progetto, che se ho ben capito dalle illazioni circolanti in Rete saresti addirittura propenso a proseguire nell’imminente futuro?
Hai centrato in pieno: i miei libri stanno entrando – alcuni più altri meno – a fare parte di un’unica “meta-struttura” narrativa. Fino ad adesso, solamente L’Occhio Sotterraneo – per la natura intrinseca del libro – ne e’ al di fuori.
La serie Sniper – che sto scrivendo per Mondadori Segretissimo e che viene riproposta dalla TEA – mi fornisce un’ottima piattaforma di riferimenti incrociati. In Sniper 2: L’Ultimo Muro (che apparirà in TEA il prossimo marzo 2005) appaiono niente meno che Wolf Hellstrom e Ivan Ratoff di Alla fine della notte. Appare anche un personaggio femminile, Dendra Yaegen, che in un futuro non troppo lontano potrebbe fare nuovamente parlare di sé.
Infine, ormai in molti dei miei libri, appare Ben Yurick, enigmatico pilota da guerra che presentai per la prima volta nel racconto Phoenix. Yurick uomo che proviene da un tempo “diverso” ma che continua a “tornare”, una sorta di testimone della follia distruttiva di tutto e di tutti.
Per cui, rispondendo apertamente alla domanda: sì, il progetto della “meta-struttura” narrativa è destinato a continuare.
Alcuni elementi della tua scrittura sono distintivi della tua penna (battute secche, stile scarno ed
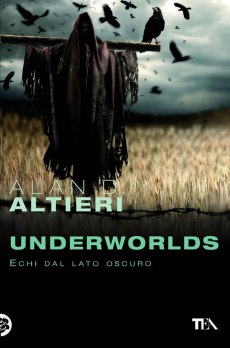 essenziale, grande ritmo e personaggi sempre in bilico tra il bene e il male, verrebbe quasi da dire “tra il peggio e il meno peggio” se mi passi l’espressione). Altri invece sembrano mutuati da grandi scuole anglosassoni, come l’hard-boiled che si riscontra nella profusione di dettagli della tua scrittura iperrealistica e il cyberpunk delle città sovrappopolate del nostro futuro, degli onnipotenti conglomerati economico-commerciali (a proposito, la tua Gottschalk-Yutani Corporation mi sembra parente stretta della Weyland-Yutani Corporation, e qui torniamo al discorso della commistione tra cinema e letteratura), degli individui in lotta contro il sistema e della tecnologia invasiva. In che rapporti sei con l’influsso di questi movimenti?
essenziale, grande ritmo e personaggi sempre in bilico tra il bene e il male, verrebbe quasi da dire “tra il peggio e il meno peggio” se mi passi l’espressione). Altri invece sembrano mutuati da grandi scuole anglosassoni, come l’hard-boiled che si riscontra nella profusione di dettagli della tua scrittura iperrealistica e il cyberpunk delle città sovrappopolate del nostro futuro, degli onnipotenti conglomerati economico-commerciali (a proposito, la tua Gottschalk-Yutani Corporation mi sembra parente stretta della Weyland-Yutani Corporation, e qui torniamo al discorso della commistione tra cinema e letteratura), degli individui in lotta contro il sistema e della tecnologia invasiva. In che rapporti sei con l’influsso di questi movimenti?
Che mi occupi di gangster a Los Angeles o di Special Forces in Medio Oriente, le mie tematiche chiave non mutano:
1) il conflitto del singolo con un enorme potere, per definizione malefico;
2) il conflitto del singolo con il proprio “lato oscuro”.
La domanda che mi poni è valida e parte della risposta può essere trovata nella risposta precedente in cui parlo dell’ibrido estremo. Ritengo che la tematica definisca lo stile. Non escludo affatto di scrivere un thriller feroce nello stile sincopato e anfetaminico che richiami quello del prodigioso James Ellroy.
Quanto ai mega-conglomerati, ebbene sì: Gottschalk-Yutani Corp. È parente stretta della Weyland-Yutani Corp. Una sua antesignana? Forse. Non dimentichiamo che il nuovo crimine planetario è la famosa ma soprattutto famigerata globalizzazione.
Si costruiscono catene di industrie pesanti a sud del confine Stati Uniti/Messico (maquiladoras), nelle quali gli operai lavorano quattordici ore al giorno senza aria condizionata, senza assistenza sanitaria e senza copertura sindacale. E si fanno lavorare bambini pakistani sotto gli otto anni di età a costruire mattoni per sedici ore al giorno a cinquanta cent la settimana. Ah, le gioie del costo del lavoro zero…
Tutto questo è destinato a scoppiarci in faccia. È proprio “lo strano attrattore” della meccanica del caos a dirlo, e non entro nei dettagli della equazione logistica e dei limiti intrinseci dei sistemi a molte variabili complesse. Quindi è proprio là, nelle mega-corporazioni, soprattutto militari, che prosperano i “cattivi” delle mie storie. Da qui le ibridazioni cyberpunk e le atmosfere alla Blade Runner di Ultima Luce, quello che potrebbe essere il destino terminale delle megalopoli.

